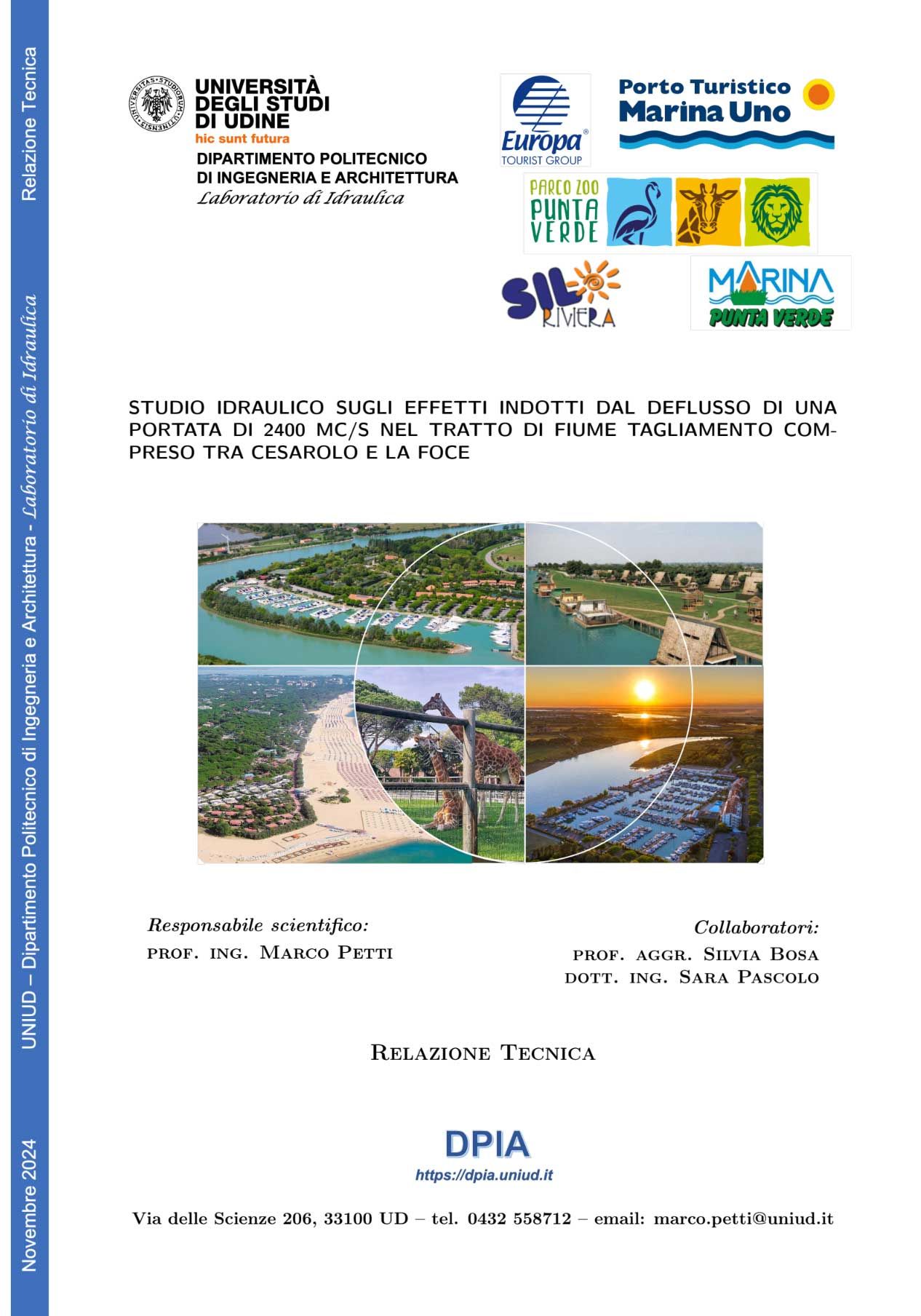Una lettura consigliata. Cosa potrebbe succedere tra Cesarolo e la foce del Tagliamento
Indice dei contenuti
Sta facendo discutere, e verosimilmente sarà oggetto di dibattito nei tempi a venire, lo “Studio idraulico sugli effetti indotti dal deflusso di una portata di 2400 mc/s nel tratto di fiume Tagliamento compreso tra Cesarolo e la foce”, redatto dal Laboratorio di Idraulica del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine.
Tale studio è stato commissionato da un gruppo di imprese legate al turismo lignanese le cui attività sono insediate proprio nel tratto terminale del fiume, ed è stato indotto dal forte aumento, ipotizzato nel prossimo futuro, della portata di deflusso nel tratto terminale del fiume, contenuto nell’aggiornamento del Piano Gestione Rischio Alluvioni del bacino idrografico del fiume Tagliamento” redatto nel 2021 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali in accordo con le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Un aggiornamento adottato con delibera n. 3 del 21 dicembre 2021 e approvata con DPCM 1 dicembre 2022, pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023, dove gli interventi di mitigazione del rischio e di difesa previsti dal PGRA 2021 – 2027 sono indicati nell’allegato III-B “Proposta di nuovi interventi”.
Un aggiornamento operativo
Va segnalato che il PGRA con questo aggiornamento è già stato approvato dal governo e quindi costituisce una norma ufficiale e vigente di governo del fiume. Andrebbe per altro anche chiarito quali procedure di partecipazione e di approvazione siano state seguite per l’aggiornamento, in particolare in materia ambientale (VIA e VAS), e quando siano state realizzate.
In tale documento è contenuta la “famosa” inversione delle portate di deflusso tra il canale scolmatore Cavrato, che passa da 2500 a 1200 mc2/s, e il Tagliamento dopo l’incile, l’imbocco cioè del canale, che aumentano invece da 1500 a 2400 mc2/s. Per sostenere questa riduzione delle portate sul canale Cavrato, si è reso necessario rivedere anche la portata transitabile a Latisana che si riduce anch’essa da 4000 a 3600 mc2/s, il tutto generando una pressione enorme in termine di volumi sia da far transitare nel tratto terminale del Tagliamento che da trattenere nel medio corso del fiume.
Lo studio conduce per mano in un percorso di costruzione della conoscenza secondo il metodo scientifico, e la sua lettura rappresenta un ormai raro esercizio di apprendimento nel quale si può apprezzare la costruzione delle argomentazioni logiche supportate dai dati e dalla misurazione degli eventi.
Ma cosa si evince dallo studio dell’Università di Udine, coordinato dall’ing. prof. Marco Petti quale responsabile scientifico, e quali problematiche mette in risalto?
Lo studio confuta i presupposti scientifici sui quali si basano i calcoli idraulici che dimensionano le portate e soprattutto la durata delle piene centenarie contenute nella proposta di modifica del PGRA, in maniera tale da influenzare e ribaltare non solo le conclusioni che riguardano strettamente la parte finale del fiume oggetto dello studio commissionato ma, in modo incisivo, anche quelle che attengono all’intera asta fluviale.
Uno dei punti di forza dello studio dell’Università di Udine è che esso si basa su dati storici che vanno indietro nel tempo di circa 140 anni e su un modello idraulico validato dalle simulazioni fatte in riferimento ai maggiori eventi alluvionali degli ultimi 30 anni, dimostratosi coerente anche per la comprensione degli eventi alluvionali del 1965/1966.
Attività a rischio alla foce
Leggendo lo studio si trovano parecchie informazioni interessanti. Dall’evidenziare che, se fossero realizzate le indicazioni vigenti dell’aggiornamento del PGRA sarebbe difficile se non impossibile difendere tutte le infrastrutture ed attività presenti in sponda sinistra del fiume in riferimento alla dimensione delle nuove arginature da realizzare, quelle attuali infatti dovrebbero essere rialzate di circa 1,5 metri.
E inoltre che i venti di scirocco che influiscono sulle maree non creano aumenti del livello di piena all’altezza di Latisana, la quale invece sarà soggetta a fenomeni di rigurgito provenienti dall’innalzamento proposto dell’incile del canale Cavrato, opera questa che si dovrebbe appunto realizzare per ridurre la portata di deflusso verso la laguna di Caorle-Porto Baseleghe.
In estrema sintesi lo studio dimostra che la proposta di modifica delle portate transitabili a valle dell’incile del Cavrato comporta una notevole riduzione dei tempi di ritorno degli eventi alluvionali, nonchè un aumento consistente della pericolosità idraulica su tutto il tratto terminale del fiume sia in sponda sinistra che destra.
Ma la ricerca è ancora più sorprendente per le implicazioni che comporta sulla restante parte del bacino. Anche se lo studio non esamina alcun impatto delle opere previste nella parte mediana del Tagliamento, i dati dello studio forniscono, anche in modo perentorio, indicazioni su come interpretare ed intervenire in tema di rischio idraulico sull’intera asta del Tagliamento.
Rivalutazione di interventi dolci nel medio corso
Innanzitutto una interessante disamina sulle caratteristiche delle precipitazioni e delle ondate di piena in tempi di cambiamento climatico che per le loro peculiarità non trovano riscontro, se non astrattamente, nella necessità di laminare gli enormi volumi (50 milioni di m3) citati nell’aggiornamento del PGRA.
Se questa valutazione è vera, e non è la prima volta che tale ipotesi emerge, trattenere a monte di Madrisio un limitato ma sufficiente numero di m3 (15 milioni) sicuramente non richiederebbe le eccezionali colate di cemento in alveo ritenute necessarie per trattenere o deviare imponenti volumi d’acqua. Altrettanto interessanti sono le valutazioni circa l’efficienza e l’importanza degli invasi naturali presenti lungo l’asta del fiume, a monte delle strette di Latisana e di Pinzano e la capacità di laminazione delle aree golenali le quali possono essere potenziate in modo naturale una volta approfondite le dinamiche che le governano e compresi i benefici che se ne possono trarre.
Lo studio dell’Università di Udine pone una lunga serie di questioni ed apre squarci di luce nel groviglio di teorie e posizioni contrastanti che hanno caratterizzato il dibattito sull’annoso tema della sicurezza idraulica negli ultimi 50 anni. E questo, paradossalmente, lo si deve ad un nugolo di imprese che detengono interessi economici nelle aree finali del bacino fluviale e che nell’aggiornamento del PGRA divengono soggette alla redistribuzione delle portate di deflusso provocate dalle opere di adeguamento idraulico previste.
C’è qualcosa di giallo…
È lecito quindi aspettarsi che la Regione Friuli – Venezia Giulia faccia le opportune valutazioni sulle risultanze di questo studio, ed inizi ad interloquire seriamente con le proprie Università e il mondo scientifico che da anni studiano i fenomeni legati alla sicurezza idraulica senza rinchiudersi a riccio sulle proprie posizioni creando divergenze che promettono, in futuro, di essere ancora più fragorose.
Alla luce dei dati riportati, e in condizioni di corretta gestione del fiume, ad oggi non c’è alcuna prefigurazione di alluvione disastrosa. Andare avanti nell’attuazione delle opere previste nell’aggiornamento può solo significare voler realizzare una serie di opere fini a sé stesse, utili forse a professionisti ed imprese e a rinfocolare conflitti fra comunità e infiniti dibattiti politici.
Il ribaltamento della gestione delle piene a valle di Latisana contenuto nell’aggiornamento del PGRA porta a riconsiderare alcuni passaggi incongrui già emersi nei lavori del Laboratorio Tagliamento del 2011. C’è bisogno di chiarezza sulle scelte fatte in sede tecnica dall’Autorità di Bacino, così come sui rapporti politici e di potere fra chi governa la nostra Regione e chi governa il Veneto.
Nel frattempo, aspettando tempi migliori, bisogna prendere atto che mentre il canale scolmatore Cavrato a suo tempo è stato costruito per far defluire le acque di piena che per motivi di sicurezza non potevano transitare sul Tagliamento, ora è il Tagliamento che deve smaltire le acque di piena che non debbono più transitare sul canale Cavrato.
Uno straordinario cambio di paradigma.