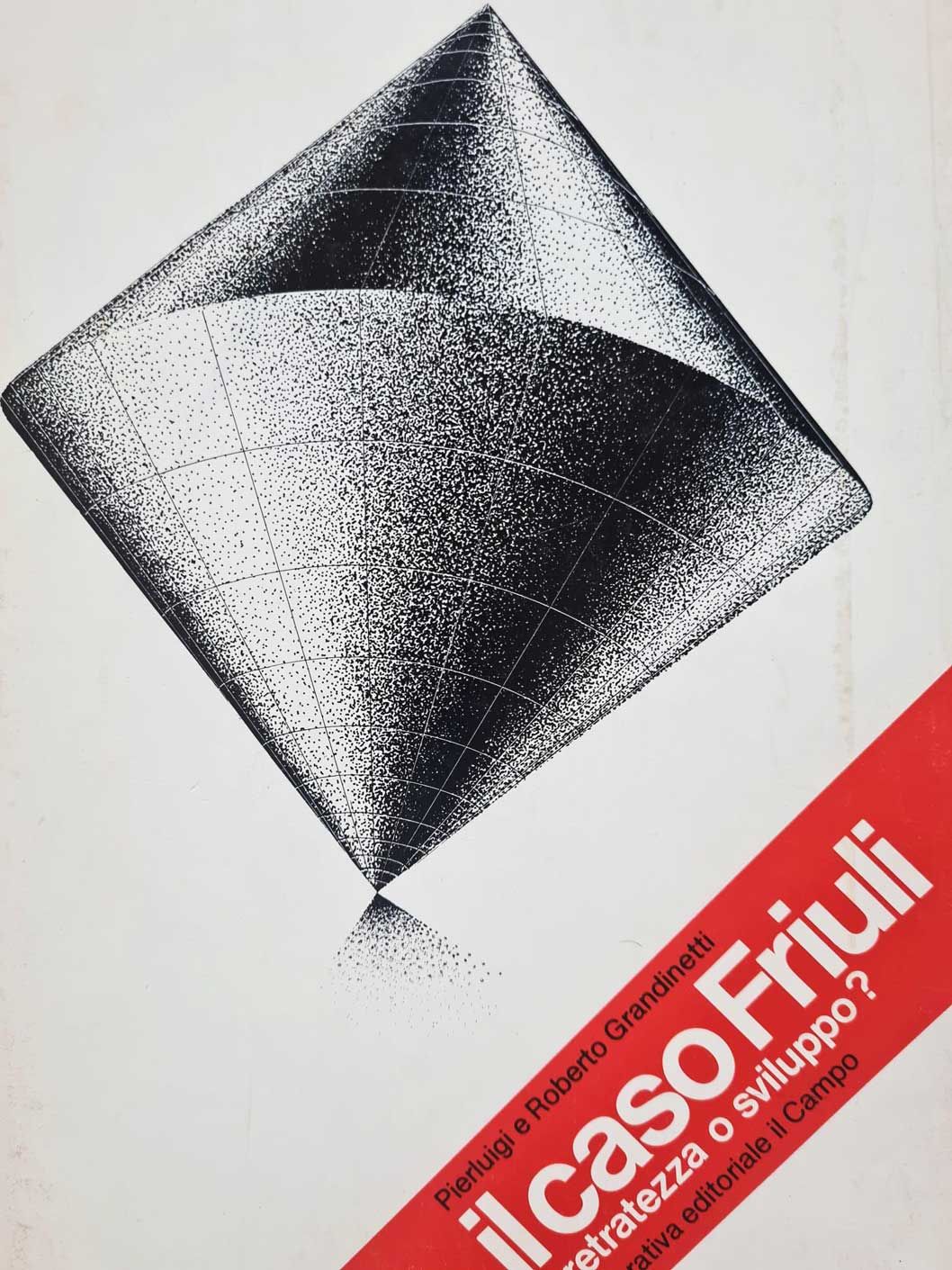Economia e società in Friuli nell’era digital-globale
Ascolta l’audio
Indice dei contenuti
Nella seconda metà degli anni Sessanta prendeva avvio in Friuli (e in altre aree dell’Italia centro-nordorientale) un processo di sviluppo economico centrato sulla manifattura che presentava caratteristiche diverse dal “triangolo industriale”. Per distinguerlo, si è parlato di industrializzazione diffusa, a sintetizzare le piccole dimensioni d’impresa, la loro matrice endogena e familiare, la diffusione spaziale delle attività produttive, e infine il radicamento nella società locale. Un modello di sviluppo che appariva di qualità mediocre per la teoria economica dominante, ma che al contrario in Friuli si rivelò sufficientemente robusto da superare la prova devastante del sisma del 1976. Guardando la situazione attuale, molte cose sono cambiate, a partire dalla realtà imprenditoriale, che include oggi una componente consistente di imprese industriali di medie dimensioni e un numero altrettanto significativo di imprese del terziario innovativo. D’altra parte, ancor più è cambiato lo scenario competitivo con cui le imprese e più in generale il sistema territoriale si confrontano, reso complesso dall’accoppiamento tra globalizzazione matura e transizione digitale. In questo scenario, sono emersi problemi inediti sul versante del fattore lavoro, dalla difficoltà a coprirne la domanda nei suoi vari segmenti all’emergere di una nuova emigrazione di “cervelli”.
Il libro Economia e società in Friuli nell’era digital-globale (Gaspari Editore) sviluppa un’ampia riflessione sulle trasformazioni in corso e sulle politiche per affrontarle, utilizzando a tal fine gli studi empirici e le fonti statistiche disponibili, oltre a diverse interviste condotte a testimoni qualificati. Le analisi sono state condotte, insieme a chi scrive, da Alessio Fornasin (demografo all’Università di Udine), Pierluigi Grandinetti (architetto e urbanista allo IUAV di Venezia), Giuseppe Parisi (consulente e formatore aziendale), Gian Pietro Zaccomer (statistico all’Università di Udine) e Sergio Zilli (geografo all’Università di Trieste). Contribuisce alla riflessione la prefazione al libro, scritta da Guido Bortoluzzi e Maria Chiarvesio, docenti di management all’Università di Trieste e di Udine.
I temi che riguardano specificamente lo sviluppo industriale in Friuli (e in Friuli-Venezia Giulia) sono tre e costituiscono altrettanti focus dell’evento di presentazione del libro organizzato da Confindustria Udine per il 12 novembre: la grande trasformazione strutturale del sistema industriale friulano; la capacità innovativa dell’ecosistema regionale; la trappola per lo sviluppo del capitale umano.
La dimensione delle imprese: la forza delle medie
La trasformazione strutturale è ben rappresentata dai fatturati aziendali 2023 inclusi nella banca dati Top500 (i settori sono quelli manifatturieri e dei servizi alle imprese nelle province di Pordenone e Udine): tra le pochissime grandi (sono 6) che superano la soglia di 415 milioni di fatturato e le molte piccole (sotto 19 milioni), esiste oggi un solido corpo di medio-grandi, medie (in senso stretto) e medio-piccole imprese (in tutto 215) che hanno dissolto la polarizzazione grande-piccolo tipica del modello di industrializzazione diffusa. Se poi si considera la presenza di gruppi aziendali, il grado di concentrazione dell’industria locale risulta ancora più elevato. Le grandi e le medie (in senso ampio) imprese presentano due importanti tratti: la loro internazionalizzazione, elevata non solo come incidenza dell’export sul fatturato, ma anche in termini di investimenti diretti all’estero di tipo produttivo e/o commerciale (per le medie si è parlato di “multinazionali tascabili”); la spiccata propensione all’innovazione, lontana dal tradizionale modello di “innovazione senza ricerca” che caratterizzava l’industrializzazione diffusa. Riguardo poi alla struttura proprietaria, emerge un quadro diverso dalla saldatura famiglia-proprietà-gestione (top management team) del passato: molte imprese sono state acquisite e incorporate in business group con sede in altre regioni italiane o all’estero; anche le imprese centrate ancora su una base familiare possono avere aperto la compagine sociale a nuovi partner e, soprattutto, la loro squadra di manager apicali include innesti esterni alla famiglia. Naturalmente, uno slittamento accentuato della struttura proprietaria verso il capitale esterno non può non destare preoccupazione. La ricerca di un equilibrio sostenibile tra capitale esterno e capitale locale rappresenta del resto una finalità prioritaria degli interventi di private equity messi in atto dalla finanziaria regionale Friulia.
L’innovazione: un modello regionale
Un sistema industriale più strutturato contribuisce a spiegarne la capacità innovativa. Secondo la fonte Regional Innovation Scoreboard (2025), il Friuli-Venezia Giulia si colloca al vertice delle regioni italiane in base all’indice generale di innovazione (una media tra un ampio set di indicatori). Certo, se si effettua il confronto con la regione europea benchmark (l’area metropolitana di Copenaghen), l’entusiasmo scema visto che il punteggio totalizzato dalla nostra regione è ben al di sotto di questo riferimento. Tuttavia, se si distinguono gli indicatori input, rappresentativi di risorse impiegate per innovare, dagli indicatori output, rappresentativi dei risultati ottenuti, il quadro cambia radicalmente: fatto 100 il benchmark, il Friuli-Venezia Giulia si ferma a 60, mentre è addirittura superiore a 100 in termini di performance innovativa. Questa evidenza segnala un diverso modello di innovazione regionale piuttosto che un gap strutturale di capacità innovativa: ad esempio, se la spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) delle imprese è relativamente bassa, la spesa in innovazione non legata alla presenza di strutture interne di R&S è relativamente alta; inoltre, la regione è ricca di KIBS (knowledge-intensive business services), ossia di fornitori di servizi capaci di supportare i processi innovativi delle imprese loro clienti, come dimostrano i diversi casi approfonditi nel libro. Non bisogna però cullarsi nell’idea della diversità vincente: in particolare, una maggiore propensione a investire in R&S risulta necessaria vista la complessità delle sfide che le imprese stanno affrontando e ancor più di quelle che le attendono. Nella stessa direzione, si avverte la necessità di una maggiore interazione tra la componente imprenditoriale e quella istituzionale del sistema regionale di innovazione: casi come LAMA FVG (Laboratorio di Meccatronica Avanzata attivo presso l’Università di Udine), un vero e proprio KIBS di natura pubblica, dimostrano quanto possa essere utile sviluppare questa interazione.
Il tallone d’Achille del capitale umano
Tra gli input dell’innovazione, quelli che destano la maggiore preoccupazione riguardano il livello di sviluppo del capitale umano – diffusione dell’istruzione terziaria tra i giovani e ricorso alla formazione permanente nella popolazione in età di lavoro – dove il Friuli-Venezia Giulia totalizza solo 41 punti. Questo dato è in linea con quanto emerge da un documento della Commissione Europea (2023), che parla di trappola per lo sviluppo dei talenti, ma che sembra più appropriato definire trappola per lo sviluppo del capitale umano, trappola in cui il Friuli-Venezia Giulia è già caduto insieme ad altre regioni d’Europa: pochi giovani regionali con elevata istruzione entrano nel mercato locale del lavoro, in valore assoluto per via dell’invecchiamento della popolazione e in termini relativi a causa di una ridotta propensione a proseguire gli studi nella fascia terziaria; pochissimi giovani con elevata istruzione provenienti dall’estero entrano nel mercato locale del lavoro; ad aggravare il primo vincolo, troppi giovani regionali con elevata istruzione escono dal mercato locale del lavoro trasferendosi all’estero (la nuova emigrazione).
Il libro discute le possibili linee di azione per uscire dalla trappola. Ad esempio, il potenziamento degli ITS Academy (il titolo conferito rientra nell’istruzione terziaria al pari dei titoli di laurea) costituisce una di queste linee, di particolare importanza vista la qualità della formazione erogata da questi istituti, la loro stretta collaborazione con l’università, da un lato, e con le imprese, dall’altro, e infine l’evidenza che la loro offerta formativa riesce a innalzare il livello di istruzione (a sviluppare il capitale umano) di giovani per i quali l’iscrizione all’università risulta per qualche motivo poco attrattiva.
E’ stato professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese prima all’Università di Udine e poi in quella di Padova, dove ora è docente senior. Si è occupato di vari temi di ricerca, tra cui: l’evoluzione dei distretti industriali, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, il terziario innovativo, le imprese nella transizione digitale. I risultati sono stati oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche, tra articoli su riviste, capitoli di libri e alcuni volumi. Autore, insieme a Enzo Rullani, di uno dei primi libri sull’economia globale (Carocci, 1996). L’area friulana e quella veneta hanno rappresentato il riferimento privilegiato di una parte significativa della sua ricerca.
- Roberto Grandinetti